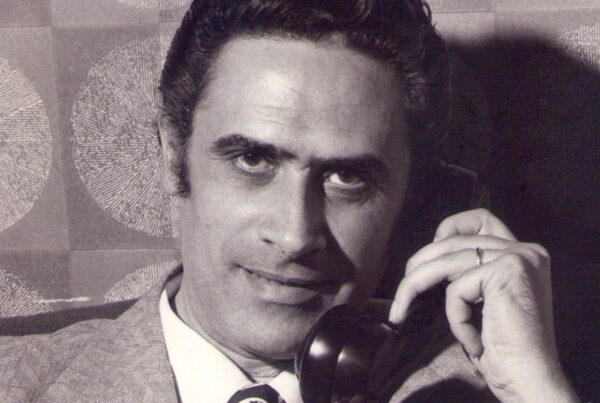Riporto ora un mio scritto, antico ormai di anni, quando lo scrissi bruciante perché resoconto di un viaggio in aereo da considerare un momento di elaborazione di un lutto che nulla poteva avere in comune con i lutti usuali che ci riserva la vita.
Qualcosa o qualcuno – non so proprio fissare una certezza – mi induce a sfidare lo stress di questa afa di luglio per ritrovarmi davanti a un marchingegno di fragili sicurezze alla ricerca di un confronto conclusivo, agognato e allo stesso tempo temuto, durante gli interminabili vaniloqui di queste mie esangui giornate, casualmente approdate a rievocare le sensazioni di un viaggio recente.
Dunque, Signore…
L’avverbio conclusivo mi pare appropriato, pur in apertura di un discorso, se questo approccio esaurisce un lungo andirivieni di dubbi e distrazioni.
Questa volta non sei stato Tu a cercarmi…
Sono qui, io personalmente, a rivolgermi a Te, nelle condizioni ottimali per non sfuggirti, per vincere le disattenzioni, le amnesie, i ricorrenti inghippi della mente che mi invadono quando mi capita di parlarti.
Perché ora ottomila metri di quota mi separano da quell’amplesso senza fine che è il mio rapporto con la terra. L’ha detto poco fa’ il pilota, stiamo volando a ottomila metri di quota su uno scatolone di alluminio, presuntuosamente possente, se vedo, attraverso il mio oblò tremare le sue ali.
“I signori passeggeri sono pregati di allacciare le cinture, di sistemare il bagaglio a mano negli appositi alloggiamenti, di mantenere lo schienale della poltrona in posizione verticale, fino a decollo avvenuto”.
Le prescrizioni mi erano apparse poc’anzi intrise di una ovvietà che serviva unicamente a coltivare una mi antica abitudine al bisogno di protezione, ad alimentare una con- dizione di ansia che mi era già usuale nel contesto di esperienze simile a quella che stavo vivendo.
E’ già in se stesso un mistero ogni volo, Signore, questo dileguarsi del peso, la velocità che assorbe, fino ad annullarla, la forza di gravità, la conquista del vuoto attraverso l’equilibrio tra volume, peso e movimento, l’impossibilità di fermarsi senza restituire al precipizio il peso dei corpi, e in- fine il dominio dello spazio, sogno antico in cui si infransero i nostri mille tentativi di vincere la prigionia della materia.
Tra uomo ed uccello c’è stato per millenni un fossato d’invidia, la pienezza della nostra impotenza di fronte allo spazio, l’aperto conflitto col bisogno d’infinito, la misura di una tensione che travalicava il microcosmo della terra per proiettarsi negli anni luce dell’universo.
Finché non venne questo surrogato di alluminio, una eclatante esibizione di potenza per vincere la levità delle ali di piume.
Adesso quel mio amore morboso per la terra sembra essersi dissolto per tradursi in questa muta trepidazione, in questo dileguarsi di ogni sicurezza, in questa totale dipendenza o soggiacenza obbligatoria alle mille regole della tecnica, alle leggi della fisica, alle cautele dei responsabili di questa ormai così usuale avventura.
Mi è sembrato, come al solito, viltà quel mio interessato rivolgermi a Te, davanti al rullaggio potente sulla pista, assalito com’ero dal timore che quella corsa disperata potesse concludersi, per mancato decollo, sugli anfratti erbosi dei prati circostanti. Ti ho chiesto allora ingenuamente di dare Tu una spinta al decollo, immaginandoti come una potenza allegramente disponibile a partecipare a questi nostri giochi spensierati.
Infatti, tutto è avvenuto regolarmente, l’impennata della fusoliera, lo stacco delle ruote da terra, la conquista del cielo.
Ora vorrei indugiare qui a parlarti, Signore, soprattutto ad ascoltare… fremiti lievi, sussurri impercettibili, flussi di pensieri ed immagini, una congiura di sensazioni tese a provocare questo mio balbettio claudicante, o magari una logorrea sconnessa e insensata, o infine un mio urlare disperato.
Abbiamo bisogno di parlare io e Te, Signore.
Perché noi due, nonostante la visibilità di una frequentazione assidua e appariscente, poche volte ci siamo parlati veramente, pochissime volte ci siamo guardati negli occhi, raramente ci siamo dati la mano.
Lasciami dunque parlare, Signore.
Senza il diaframma del dubbio, senza le nebbie di quel tuo essere e non essere, comparire e dileguarti, travolgermi o lasciarmi nel buio.
Siamo soli, Signore, in un crocevia da cui non riusciamo più a sfuggirci reciprocamente, io e Te.
Prima pensavo che la solitudine fosse un mio marchio esclusivo, una mia condizione naturale e irreversibile, un destino inespugnabile che mi avrebbe accompagnato per tutta la vita come l’ombra della mia figura.
Ora mi accorgo che assieme, io e Te, formiamo due solitudini.
Perché anche Tu ami tuffarti nella solitudine, dimenticare per un po’ la congerie infinita dell’essere, la moltitudine innumere degli atomi che chiamano umanità, per dedicare un qualche frammento del Tuo tempo a me serrandomi in un dialogo senza respiro.
Creare una tua solitudine per piegarla alla mia…
Perché in Te la solitudine coincide con la passione, con questo tuo incredibile innamorarti dell’uomo e appassionarti al suo destino e rincorrerlo in tutti i labirinti dell’es- sere.
Vorrei dirti che non capisco la vita, Signore, né per quale ignota e misteriosa ragione io l’ami, pur senza capirla.
Questo nostro ininterrotto morire cominciato sin dal primo gemito, questo lento, inesorabile marcire di cellule, l’affanno dei giorni, la brevità, l’evanescenza, la vacuità, l’estrema nostra fragilità di farfalle bellissime e vane.
La vita è un quotidiano morire e la morte mi appare come un precipizio senza approdo nel quale un improvviso abbaglio di luce stordisce e blocca la mente, scagliandoci in un paralisi inspiegabile, la morte è una narcosi senza fine, un dominio assoluto e vincente.
La morte…
L’aereo adesso entra in una nube, e l’impatto diventa rivelazione improvvisa di velocità, un lattice denso e fuggente violato da una prepotenza d’acciaio, un precipitare nel vortice di infinite bambagie.
Eppure ci avevano descritto le nubi come il luogo della Tua dimora, orpello appariscente della Tua maestà per ridurti entro gli angusti confini del cielo.
Uno sgomento improvviso ora mi assale e mi sorprendo con un gesto istintivo a coprirmi il volto con le mani, probabilmente a celare presunte pusillanimità di fronte al curioso scandaglio dei miei compagni di viaggio.
Le mani ora indugiano con lentezza compiacente, premono, frugano, spostano la pelle, svelano la consistenza delle ossa… Le orbite immaginate vuote, le fosse nasali, la prominenza della bocca a contenere la scatola della mascella con la doppia fila di denti, il vuoto dei tre molari mancanti che a breve una protesi dovrà riempire… tutta una macabra rivelazione di essenza, la mia effigie tra venti o trent’anni… o prima…
Non è possibile che arrivi a quaranta… Forse sarà subito, da qui a qualche attimo, o tra una settimana, o tra un anno…
Chi può orientarmi in questo oroscopo aggrovigliato del tempo?
Ecco, guarda, Signore, questo nostro rimanere sospesi ad un filo, questa attesa o paura di qualcuno che deve venire e non sai quando arriva, questa quotidiana altalena della vita, la morte che non rispetta mai i turni, che non conosce precedenze, né gerarchie, né ragioni.
Uno piange, l’altro muore, ineluttabilmente, inesorabilmente.
La morte è una scommessa sulla durata che travolge ogni nostra capacità di progetto ed ogni tentativo di dominio del tempo.
Nemica della ragione è la morte. Paranoia dell’essere. Apoteosi del non senso. Disperata caduta nell’assurdo.
C’è un bambino sulla poltrona davanti alla mia, scalpita, frigna, fa le bizze, quindi esplode in un pianto dirotto.
Perché piangono i bambini, Signore? Da millenni noi Ti inchiodiamo a questa interpellanza e Tu ci gratifichi di un silenzio che aumenta uno sgomento senza fine.
Il silenzio di Dio, la fuga davanti all’enigma del dolore?
Non è l’affanno de giorni, la fragilità della cellula, l’evanescenza della mente, l’incalzare della disfatta, che è in giuoco. E’ la sofferenza immotivata, il dolore non retributivo, il dominio totale del male, ciò che assedia la nostra ragione e reclama una qualche scintilla di luce.
C’è un punto oltre il quale la motivazione cede, la fede diventa muta e tutto si chiude in una soggiacenza disperata alla signoria del dolore e del male.
Perché noi, Signore, ultimi arrivati della storia, ci portiamo addosso, ancora oggi, quella piaga purulenta e in- guarita di cinquanta milioni di morti, quell’interminabile sequenza di larve dolenti avviate ad una sconfitta senza senso nei tempi di morte da noi stessi inventati.
E c’era allo e c’è ancora quella lacerazione gridata attraverso il pianto dei bambini e la sofferenza degli incolpavoli.
Se il dolore è espiazione, retribuzione per un male commesso, come può pagare l’innocente, se egli il male sconosce? In base a quale mostruosa dimenticanza può essere lasciato in sua balia?
Se le sue mani e il suo cuore sono rimasti incontaminati, esenti dall’infezione del male, perché chiamarlo a scontare colpe sconosciute?
Lo so, Signore, che la risposta sta in Te, che Tu sei la risposta, che essa esplode come un bagliore improvviso nella nostra proiezione oltre il tempo, al di là della storia e della carne, in una misura impalpabile di futuro dove la misericordia diventa compenso conclusivo, equilibrio dell’essere, vittoria sul dolore.
Ma qui, ora, davanti a queste ferite aperte e sanguinanti, chi mi dà la capacità di distogliere gli occhi dal presente, di scrutare le tue lontananze, se una miopia tanto tribolante come la mia mi fa da paravento?
Signore, a volte Tu fuggi, lasciandoci in balia della nostra solitudine, nelle nebbie della mente, davanti a grovigli di inquietudini che arroventano la nostra vita.
Siamo soli a lanciare la nostra sfida quotidiana e in essa a riscoprire la coscienza di esistere ingaggiando una titanica lotta per liberarci dalle scorie della materia e conquistare un qualche baleno di luce.
Questo mio stesso ritrovarmi sulla poltrona di un aereo non è forse una sfida a quello che noi chiamiamo destino e che io ho sempre immaginato come sostanza della Tua volontà?
E questo mio trasalire ad ogni vuoto d’aria, ad ogni pur minima vibrazione delle lamiere, non appartiene forse a una mia fragilità acquisita, ad una mia soggiacenza al ricordo, a questo cullarmi tra la necessità di vivere, appunto sfidando la vita, e l’incombenza invadente della morte che riempie ogni attimo della mia vita?
Signore, Tu lo sai, per me il ricordo è una stimmata indelebile su cui l’unguento del tempo spesso non porta leni- mento.
Il ricordo, Signore, il ricordo…
…quella lunga, interminabile attesa, nella hall dell’aereoporto, stranamente inquietante se il cuore respingeva il presagio davanti alle lunghe processioni di passeggeri in arrivo che mi sfilavano davanti inutilmente… Era uscita indenne dalla tragedia di aprile e sembrava impossibile che la morte giocasse ancora a nascondino con lei in quella notte dell’antivigilia di Natale del 78.
Ma era strana quella gentilezza Alitalia, strano quel velo di sgomento sui volti, strana quella vecchietta dal cappellino a strisce e dal cappotto verde: entrava e usciva dal box delle informazioni a rubare notizie e a scongiurare sciagure.
Alle tre e mezza del mattino la stanchezza si dispose ad accettare le ragioni della speranza, la sua vittoria sui presagi, mentre essa già da tre ore aveva concluso il duello impossibile rendendo le sue povere armi alla morte.
Ed io non so per quale sorta di inconsapevole rimozione noi allora coltivammo l’illusione di un epilogo improvviso e fulmineo, fugace come un lampo, senza il tempo di capire, senza quello di pensare, senza memoria del passato, senza paura del salto.
Il tempo breve di un segno di croce, di un ricordo fugace per noi, di un grido spento sul nascere..
Noi rifiutammo l’impatto atroce con l’invincibile terrore, con la solitudine estrema e assoluta, davanti alla morte.
Perché essa, Signore, è morta da sola, più sola di tutti gli altri morti della terra… Il mare l’avvolse nelle sue acque come un innamorato tra le sue braccia… la cullarono per venticinque giorni le sue correnti, mentre i pesci giravano alla larga davanti al mostruoso groviglio.
E Natale fu una veglia di morte, seduti attorno a un pensiero fisso: la brama di un corpo tra noi, un corpo da baciare e piangere ai rintocchi della Messa di mezzanotte.
La mamma aveva preparato tutto, come ogni anno, io e Gianni avevamo costruito il presepio, di roccia e cartoni, diverso dagli altri anni, per suscitare il suo giudizio carpirle un sorriso.
Ora mi sta davanti quel carnevale di morte, lugubre fin zione segnata sui corpi intatti, paradosso, follia, scempio, dissoluzione di tutte le sembianze, teoria di statue di marmo, alabastro bruno lucente a fissare l’ultimo gesto… e bambini come bambole di cera abbandonate nel lungo corridoio di medicina legale come dopo l’ultimo gioco…
Ecco la tua vittoria, la tua atroce beffa, morte impazzita durante la tua libera uscita del 23 dicembre!
Comincia adesso una recita curiosa e inquietante, una hostess davanti a me si affanna in un intrigo di gesti e parole ad illustrare comportamenti obbliganti, in caso di pericolo, mentre una voce fuori campo segnala salvagente sotto la poltrona e maschere antigas di cui si descrive l’apparizione improvvisa come un macabro nunzio, davanti a ciascun passeggero, per essere indossate a finale esorcismo di rischi probabilmente inamovibili… ed è tutta una minuta descrizione di cautele e prudenze che attrae una diffusa quanto diffidente attenzione dei passeggeri.
Mi sembra di essere proiettato in un infantile gioco di scherma orchestrato con disinvolta presunzione da un nemico mille volte più astuto e potente, inanità di una trincea difensiva di fronte alla sofisticata ingegneria di un apparto di morte invincibile.
Anche le statistiche concorrono, infatti, a confermare un primato di sicurezza agli aerei, rispetto alle automobili, ai treni e a qualunque macchina adibita ai trasporti, ma col compenso indiscutibile di un tasso infimo di possibilità di salvezza… La morte accetta di essere relegata nella categoria dell’eccezione, ma pretende una completa signoria all’interno degli spazi che le sono riservati.
La morte impazza in una frenesia senza misura… e il ricordo che torna ad irretire la mente.
Quel lugubre stanzone nel cuore della vecchia Palermo, la vita impressa come marchio su innumerevoli oggetti sparsi sulla scacchiera umida del pavimento: bocche spalancate a vomitare pensieri come aculei sulla pelle bianca di brividi… scarpette e cappottini a invocare quasi gridando piccoli corpi lontani, un pettine, uno specchio, un necessaire da viaggio, pellicce inzuppate d’acqua salmastra, la divisa del pilota e cento piccoli grandi segreti violati dallo squallido, impudente furore della morte… della morte che aleggiava su tutto col suo lezzo ripugnante, scagliandoci addosso i ricordi come pietre.
E siamo ancora qui, Signore, come ebeti a ricordare le dure percosse di una morte così improvvisa, così lacerante, così carica di mistero, così radicalmente ingiusta, così folle, così apocalittica…
Attraverso il mio finestrino ora appare un tramonto di opale su cui sembra scivolare il nostro volo come su una viscida corsia di ovatte inzuppate.
Sotto di me la sagoma rassicurante delle Eolie e più in là la consistente durezza della costa siciliana.
Ad un tratto mi è dato di rivivere la liberante esultanza di marinai che avvistano la terra dopo estenuanti quarantene.
Io amo la solidità della terra, la sua solidità rassicurante e protettiva, l’impatto del piede sulla durezza, la certezza di non sprofondare nella flaccida inconsistenza dell’acqua o dell’ aria, la vittoria del concreto sul timore di precipitare in un abisso illeggibile. E di notte mi perseguitano incubi di improvvise sabbie mobili che mi divorano scagliandomi in uno sgomento senza appigli.
Signore, ho un bisogno incontenibile di sicurezza e sogno di adagiarmi in un giaciglio stabile e definitivo in cui sciogliere i sogni – durati tutta la vita – di radicale novità e cambia-mento… un’uscita dal tunnel dell’usualità in cui si annidano tutte le prepotenze del male per riappropriarmi di una misura sconosciuta di accoglienza e di pace.
E’ per questo che mi sento invaso da una irrequietezza che non so vincere di fronte alla distanza che ancora mi separa dalla terra.
Sotto di me il brulicame lontano dei paesi, la frenesia delle auto lungo la sinuosità delle strade, tutta una percezione dell’affanno dell’uomo per strappare alla terra una qualche risposta, o infine l’impervia refrattarietà delle montagne, le trame oscene di Sigonella tra file di eucaliptus come lontane processioni di salmodianti, i fianchi lunari dei pendii dell’ Etna, fino alle evanescenze impalpabili e dolci del golfo di Augusta… tutto si connette in un mosaico di immagini che conducono all’unico desiderio di approdo.
Signore, sta per finire questo viaggio e sento che già in- combe la sera, una sera piena di suggestioni inspiegabili, un acconto di mistero da cui mi sento ormai soggiogato.
Abbiamo iniziato la discesa, l’ha annunziato poco fa’ lo steward, verso l’aeroporto, dove prevediamo di atterrare tra venti minuti circa… il tempo a terra è buono e la temperatura è di 18 gradi centigradi… i signori passeggeri sono pregati di allacciare le cinture e di non fumare…
Signore, sono stanco di volare, soprattutto con ali non mie, di fingere una capacità di dominio che non mi com- pete, di sfidare il mondo tramando presunzioni e ostentando le mie geometrie di giocoliere.
Questa condizione di Icaro irrequieto e sognante, questa strana e infantile volontà di domare la precarietà di ali posticce affidate alle esigue forze di povere braccia, è tutto ciò che resta del mio progetto di vincermi.
Adesso so che mi aspetta un precipizio misterioso e in- quietante, che però immagino pieno di lusinghe consegnate alla vertigine del non conosciuto.
Sono stanco, Signore, Tu lo sai, stanco per aver vissuto due volte la stessa vita, tuffandomi in una insonnia senza limiti per lambire le utopie di un mondo in cui si fossero dissolte tutte le dipendenze e gli uomini fossero tornati a guardarsi negli occhi sedendo sulla stessa panchina.
Stanco e ferito, Signore, da armi terribili in mano di uomini privi di ogni pudore e scrupolo.
Sapessi quante volte mi hanno colpito nel sonno, senza motivo e senso, per una misura esorbitante di accanimento e perfidia!
E tuttavia è stata una stupenda avventura la vita! Un camminare in mezzo alla folla anonima e distratta soggiogata da infinite ansie ed assilli, inventandomi, per contra- sto, una solitudine in cui consumare sgomenti e delusioni.
Ora mi resta questa fedeltà indeclinabile e orgogliosa ai molti pudori e alle ostinate timidezze, il non chiedere nulla e il saper attendere, la disponibilità e la fierezza, l’esigenza di fare e il rischio di fallire, il dubbio di una soggiacenza inconsapevole a personali tentazioni e a vanità impalpabili.
Nella quiete apparente irrompe, a un tratto, il rumore dei freni ed è un trasalimento improvviso che mette in moto conflitti e ansietà da poco assopiti.
Siamo ancora alti, rispetto alla terra, pur se le immagini rivelano contorni e particolari imprevisti.
Ogni atterraggio è sempre una trepidazione vincente, un conquistare palmo a palmo la terra affievolendo gradualmente i timori fino a dissolverli nell’impatto col suolo.
Provo a vincere il mio curiosare attraverso l’oblò e ad impormi l’isolamento di un minuto, distacco totale dal reale circostante ad occhi chiusi per affidare al silenzio il crogiuolo dei pensieri.
Ora sono una piuma nelle Tue mani di vento ed ogni ansia si scioglie in una disponibilità serena e consolante.
Sul proscenio del buio passano larve di immagini e suoni, lontane dissolvenze di ricordi, strani sopori, improvvise dolcezze.
Sulla vita ho scommesso, Signore, chemin de fer, roulette, o più banale lotteria di paese, a esorcizzare la follia delle cose, imprigionando la speranza nelle vette della Tua parola.
Cielo e terra sono espressioni prive di senso adesso, categorie di pensiero su cui si è adagiato per millenni il nostro bisogno di certezza.
Il rischio sta nella risposta, il rischio sei Tu, Signore, che stimoli alla sfida, io, che la sfida ho accettato.
Scopro sotto di me il mare, un’infinita sete lucente e increspata sulla quale si adagia l’interpellanza finale.
Terra o mare?
Siamo a qualche metro dall’azzurro, così almeno a me sembra, se la fata morgana degli occhi non congiura anche essa a stordirmi.
Mare o terra?
Se abbracciassi il mare in questo momento, poteri sperare in un cunicolo di salvezza affidando alla mia fragile abilità di nuotatore asmatico la conquista della riva.
Perché c’è una riva, Signore, la vedo…
Ancora chiudo gli occhi giacché non voglio incrociare con lo sguardo la pista…
La terra, Signore, la terra…
Tratto da “Il viaggio, la memoria, il sogno”, 1989